Pensieri su “convivialità”, social network e dintorni.
Con molto ritardo, pubblico alcuni pensieri scritti all’indomani della chiusura del nodo Mastodon nebbia.fail.
Pur con tutte le difficoltà che i progetti di questo tipo hanno incontrato nell’ottenere diffusione, continuità e sviluppo di una comunità il cui senso vada oltre l’autorappresentazione del proprio ego tra estranei; non ritengo che il concetto di social network, in tutte le sue accezioni che vanno dalla piattaforma di micro-blogging ai sistemi di messaggistica “evoluta”, sia intrinsecamente inadatto ad un’autogestione comunitaria, che possa svilupparsi e approfondirsi con ricadute che coinvolgano anche il territorio sociale della stessa.
L’esperienza di Nebbia, compresa la fine del progetto, non mi ha fornito risposte definitive alle grandi domande sull’effetto che i social network hanno sulle qualità umane della comunità che li abita, ma ritengo, forse con una punta di presunzione, che la pratica mi abbia fornito domande migliori di quelle che possono scaturire dalla pura critica.
– I social network portano ad un’esperienza intrinsecamente gamificante?
Una tra le critiche più dirette e fondate ai grandi social network commerciali è che influenzano gli utenti per spingerli a passare più tempo possibile sulle loro piattaforme, al fine di massimizzare la loro esposizione alle inserzioni commerciali, e secondariamente assorbire parti sempre maggiori del loro tempo e vita.
Questo meccanismo si sviluppa attraverso incentivi come notifiche di like e condivisioni, che fanno sentire alle persone di ricevere attenzioni, e mostrando contenuti dall’alto impatto emotivo, che istigano una interazione esasperata per catturare l’attenzione delle persone coinvolte.
Questo fenomeno, qui esposto nella sua forma più ristretta, viene definito “gamificazione”, tracciando un parallelo con i videogiochi, chiaramente con accezione negativa.
Ma gli elementi che compongono questo meccanismo, sono necessariamente negativi? Una delle spiegazioni più meccaniciste del fenomeno è che like, condivisioni e messaggi provocano un “flusso” di rilascio della dopamina nel cervello, funzionando come ricompensa neurochimica e provocando dipendenza.
Troviamo questa spiegazione, tratta di peso dalle neuroscienze cognitive, e nello specifico dalla narrazione che circonda le dipendenze e l’uso di sostanze, molto riduttiva e poco soddisfacente, tanto per quanto riguarda l’uso di sostanze che per i social network.
Gli esseri umani sono sempre stati propensi, a tratti vittime, alle dinamiche di gioco, e non crediamo che eliminarle completamente sia possibile o auspicabile.
Il gioco è una pratica in parte innata dalle profondi componenti sociali ed educative, il fatto che grandi aziende ne facciano una trappola per l’attenzione e una fonte di guadagno non squalifica l’importanza di una componente di gioco in altri contesti.
Una domanda più interessante è: che effetto hanno sulle persone le dinamiche di gioco attualmente implementate in un social network senza fini commerciali come Mastodon e le piattaforme del Fediverso?
Queste dinamiche migliorano o peggiorano la nostra esperienza e il rapporto con il resto della comunità?
In che modo potrebbero essere migliorate e rese più costruttive?
Una volta che come comunità ci si riappropria dello strumento che rappresenta il campo di gioco lo spettro di domande che è possibile porsi aumenta a dismisura, e la parte migliore è che si possono anche applicare le risposte.
-I social network sono inevitabilmente piattaforme finalizzate alla “pornografia emotiva” e promozione dell’ego?
Un’altra critica che scaturisce dagli elementi più evidenti dei social network commerciali riguarda l’utilizzo dell’immagine e dell’autonarrazione a fini di autopromozione, che esacerbata dal sistema di cattura dell’attenzione degli utenti viene ingigantita fino a diventare essa stessa un fenomeno commerciale, incarnando perfettamente il concetto di società dello spettacolo del noto filosofo francese Guy Debord1.
Anche su scala più piccola è possibile notare una sorta di osservazione della vita delle altre persone, insieme all’espressione della propria, fenomeno che può diffondere mode, pratiche e rivalità di vario valore.
Uno dei pezzi centrali di questo sistema sono gli algoritmi (algoritmo è una qualsiasi formula matematica) che governano il flusso di post che le persone osservano, ingigantendo la portata dei contenuti che sono ritenuti catturare più attenzione.
Questo tipo di gestione delle bacheche virtuali non è per nulla obbligatoria nelle piattaforma libere e autogestite, se una qualche forma di filtraggio è spesso necessaria, è importante che questa sia consapevole, e frutto di una scelta delle persone che le popolano. In altre parole, se la creazione di una “bolla” può essere utile per selezionare il materiale che vogliamo, è fondamentale che sia frutto delle nostre scelte e sotto il nostro controllo.
Una volta estratto il fenomeno dell’autonarrazione dal meccanismo di mercato delle grandi aziende, è fondamentale chiedersi quale sia l’effettivo impatto sulla vita delle persone, in caso contrario si rischia di scivolare in una sorta di moralismo.
La volontà di rappresentare parte della propria identità negli spazi virtuali è intrinseca alla coscienza individuale, e ritengo che il benessere della collettività non possa basarsi esclusivamente sulla repressione espressiva delle individualità che la compongono.
Questo è ancor più vero nel caso di piattaforme basate su una rete di piccole comunità, dove non vi è la percezione di performare di fronte ad un infinito “pubblico silenzioso”, e i messaggi sono destinati in primo luogo ad un gruppo definito, che spesso condivide alcuni tratti culturali comuni.
Si apre un discorso ulteriore sul concetto di “identità virtuale” come prosecuzione della nostra personalità, liberata dal timore della repressione e ripercussioni da parte dei rapporti di potere che siamo costretti a subire nel mondo. Non possono esistere spazi completamente sicuri in un mondo che non lo è, ma quelli che si avvicinano lo sono perché gestiti dalle persone che lo vivono.
Questi ragionamenti su autorappresentazione, “bolle” di contenuti e identità virtuali sono un punto di partenza per domande più specifiche sul come esistere in rete.
Esistono metodi più efficaci della pura repressione per limitare il traboccare di spinte negative da un mondo intorno che sempre positivo non è? (L’uso esclusivo di repressione automatizzata, anche se benintenzionata, è facilmente aggirabile, come nel caso della diffusione del termine “unalive2”.)
In che misura è possibile gestire un equilibrio tra scala della comunità virtuale e autogestione della selezione dei contenuti?
Come utilizzare le possibilità date dalle “identità virtuali”, e relativo anonimato, per gestire insieme uno spazio che sia più accogliente della società in cui è inserito, riducendo il più possibile le aggressioni e soprusi?
L’autogestione di uno spazio pone sempre il problema del rapporto con il mondo circostante, con le sue storture e iniquità, che spesso in modo più o meno grave si riflettono inevitabilmente su chi lo abita. Rinunciare ad uno spazio autogestito non elimina il problema, ma solo una possibile soluzione.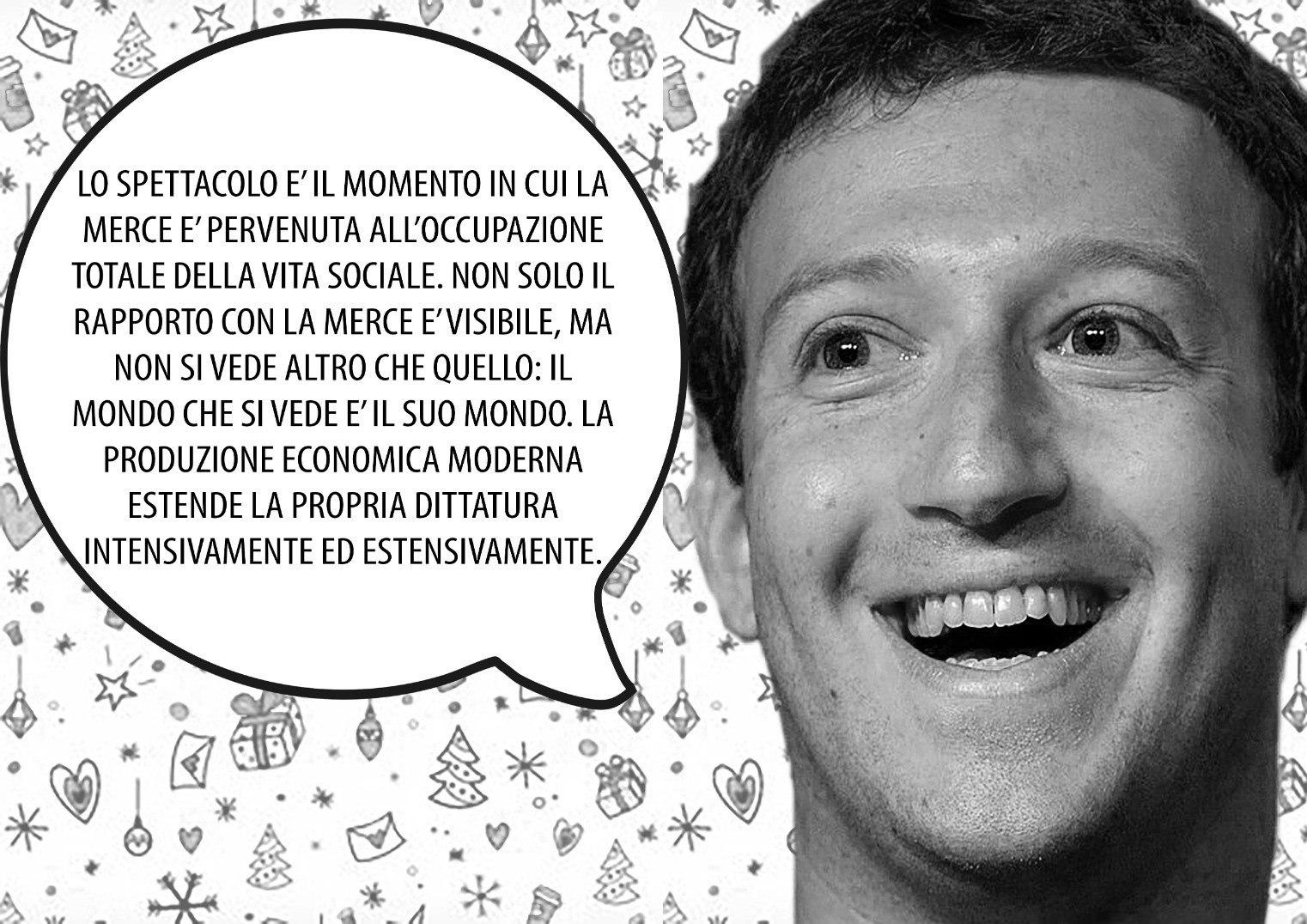
-I social network possono essere una “tecnologia conviviale”?
Riguardo al rapporto tra tecnologia, persona e comunità, è divenuto in una certa misura conosciuto il concetto di “conviviale”, caratteristica difficile da qualificare che indicherebbe la misura in cui uno strumento è propedeutico allo sviluppo di rapporti umani benefici e significativi.
Dal mio punto di vista gli strumenti tecnologici non esistono in un vuoto pneumatico, essi sono parte di un ambiente, inteso come contesto sociale e tecnologico, sviluppato con varie finalità, e attorno a loro ruota una comunità con una propria cultura e caratteristiche.
Chiedersi se una tecnologia sia o meno “conviviale” non può quindi prescindere dal considerare sia il contesto in cui nasce, che le persone che la usano.
Penso che, uscendo parzialmente dal discorso sui social, sia interessante considerare l’effetto di Puntello3, una istanza Gancio attiva a Milano, progetto in cui l’assemblea di Nebbia è confluita.
Per chi non lo conoscesse, Puntello è semplicemente una bacheca di eventi, pensata per la sinistra extra-parlamentare milanese, dove qualsiasi gruppo, collettivo, spazio sociale può richiedere un account e postare i propri eventi a sfondo politico.
Per chi veniva dall’assemblea di Nebbia, è stato presto evidente come Puntello avesse caratteristiche immediatamente più “conviviali” dell’istanza Mastodon, perché gli eventi postati riportavano immediatamente le persone a incontri sul territorio, dove la voce dell’esistenza di Puntello si diffondeva attraverso comunità vicine agli spazi e sottoculture interessati, creando così un circolo virtuoso che ha potenziato sia Puntello stesso che le comunità che vi sono rappresentate.
Sia Gancio (il software “madre” di Puntello) che Mastodon fanno parte di una rete di piattaforme interoperabili chiamata Fediverso4. Un insieme di software che possono comunicare tra loro tramite un protocollo comune (Activitypub).
Questo fa sì che un’istanza Gancio possa postare gli eventi su una Mastodon, dove le persone possono a loro volta interagire riguardo agli stessi.
Questo scenario apre ad una serie di domande non più limitate dall’attuale forma dei grandi social commerciali, nelle quali è possibile mettere in discussione distinzioni che erano in realtà i confini delle scatole dove i grandi padroni delle piattaforme volevano costringerci.
Cosa è un social, e quali sono i suoi confini se le piattaforme sono interoperabili?
Quando ci chiediamo se una tecnologia è “conviviale”, ci limitiamo alla singola piattaforma o consideriamo l’ambiente in cui è inserita e collegata, e il rapporto reciproco che ha con le comunità sul territorio?
Come possiamo rendere un determinato strumento più propedeutico allo sviluppo di rapporti umani positivi, nel contesto di un dialogo tra tecnologia, ambiente, e comunità che lo vivono?
Quando si considera un social network non come una scatola chiusa, ma un elemento di un ambiente complesso, è possibile sviluppare circoli virtuosi con altre tecnologie e il contesto in cui si inseriscono. Quando ci si riappropria di uno strumento è possibile assemblarlo in modo che la sua funzione primaria non sia fare del male alle persone per estrarre valore dal loro tempo e dati, ma allargare e approfondire la comunità che lo popola.
Per una visione intersezionale del rapporto con tecnologia e social network.
Penso che l’esperienza dei social network non sia riconducibile alla sola stimolazione di piacere tramite neuro-trasmettitori sinaptici, ma rappresenti il punto d’incontro tra medium, ambiente in cui è inserito, e cultura della comunità che lo popola. Utilizzare lo stesso software con una diversa combinazione di fattori porterà inevitabilmente ad un risultato diverso.
Difendo la necessità di uno spazio gestito assieme dalle persone che lo vivono, dove autodeterminare la propria rappresentazione, reclamare il controllo delle nostre “bolle”, e comunicare fuori dai meccanismi di mercato, senza timore di rappresaglie personali o che il potentato di turno ci venga a prendere a casa.
Desidero un ambiente di interoperabilità fra tecnologie libere, dove il confine tra l’una e l’altra è incerto e sfumato, reciprocamente fuso con la comunità che lo attraversa e il territorio dove essa vive, in un circolo virtuoso dove reale e virtuale si sostengono a vicenda.
Più di ogni altra cosa, penso che la teoria debba servire la pratica, e non viceversa. Che sia meglio costruire un’alternativa e fallire, piuttosto che atteggiarsi a consumatori critici sulle stesse piattaforme che disprezziamo.
Per questo ritengo fondamentale creare e sviluppare progetti, e continuare a cercare domande migliori, tramite la sperimentazione di modi per vivere e riappropriarci della tecnologia antitetici a quelli delle grandi entità del profitto.